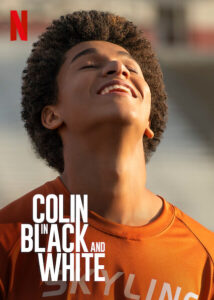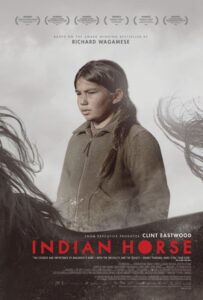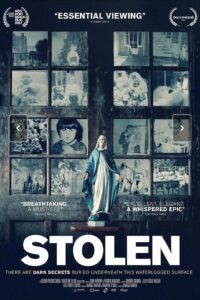Tempo di lettura: 3 minuti
Il film Per il mio bene parte con una promessa importante: affrontare un tema delicato e profondo come quello del diritto degli adottati a conoscere le proprie origini, intrecciato a una vicenda tragica di una madre che ha dovuto abbandonare.
Ma lo fa con un tono distaccato, fin troppo tranquillo, che lascia lo spettatore disorientato. Una promessa, quindi, che resta disattesa.
Per certi versi è uno di quei film che sembra parlare solo a chi è già dentro l’adozione, a chi sa già cosa può accadere e cosa significhi portarsi addosso un vuoto, una domanda. Per tutti gli altri, il messaggio resta opaco, poco incisivo, quasi secondario.
La protagonista, Giovanna, è a capo dell’azienda di famiglia specializzata nella lavorazione del marmo, ereditata dal padre e gestita insieme alla madre Lilia. È una donna riservata, dedita al lavoro e alla figlia quindicenne Alida. Quando scopre di essere gravemente malata e che l’unica possibilità di salvezza è un trapianto urgente di fegato da un consanguineo adulto, decide di confidarsi con Lilia. Ed è proprio in quel momento che riceve una verità sconvolgente: è stata adottata da neonata.
Quel segreto, tenuto nascosto per tutta la vita, apre in lei un vuoto improvviso e l’urgenza non solo di salvarsi, ma di scoprire chi sia la madre biologica, l’unica persona che potrebbe ridarle la vita — stavolta in modo consapevole.
La ricerca della madre naturale nasce con uno scopo utilitaristico, legato alla sopravvivenza. Solo in un secondo momento — e in modo piuttosto tardivo — la protagonista ammette che questa ricerca ha colmato anche un vuoto affettivo. Ma è un riconoscimento che arriva tardi, quasi per caso, e che non basta a dare spessore alla narrazione.
Giovanna riesce a conoscere la madre solo nello spazio di pochi giorni, e solo attraverso il suo dolore: Anna la rifiuta. Non c’è modo per le due donne di incontrarsi davvero come persone, in una relazione reale. E anche questo lascia l’amaro in bocca, come se il film volesse evitare di rappresentare un contatto affettivo tra madre e figlia.
Ed è proprio questo il nodo centrale: la ricerca delle origini, così carica di significati identitari, esistenziali e affettivi per chi è adottato, viene ridotta – almeno in partenza – a una necessità medica. L’urgenza fisica prende il posto dell’urgenza interiore.
E la madre biologica viene rappresentata nel modo più estremo: una donna che ha subito uno stupro da giovane, che ha partorito in anonimato e che ha perso l’unico figlio cresciuto con sé in un tragico annegamento nella notte della violenza. Una scelta narrativa che giustifica il suo silenzio, assolve la decisione di nascondere tutto e sposta l’attenzione sull’empatia per lei, non sulla comprensione del bisogno della figlia.
È qui che il film inciampa. La scelta di rappresentare la madre biologica come vittima di stupro legittima il segreto, rendendo quel silenzio non solo comprensibile, ma quasi sacrosanto. Ed è vero: esistono storie così. Ma quando si utilizza un caso-limite per rappresentare un tema collettivo, si corre un rischio enorme: far passare l’eccezione per regola. E in questo film, quel rischio si concretizza. Lo spettatore non esce con l’idea che gli adottati abbiano diritto a sapere. Esce con l’idea che, a volte, sia meglio non sapere.
Il film commuove solo in una scena – quella conclusiva – ma non scuote, non educa, non denuncia. E soprattutto non mette davvero in discussione la crudele “legge dei 100 anni”, che ancora oggi in Italia impedisce agli adottati di conoscere l’identità della madre biologica se quest’ultima ha scelto l’anonimato. Una legge che nega il diritto alla verità, ma che in questo film resta sullo sfondo: viene nominata, ma non spiegata, non affrontata, non problematizzata.
Questo approccio smorzato, trattenuto, tocca un problema più ampio del cinema italiano contemporaneo. C’è un certo stile, ormai dominante, che sembra temere l’emozione. Gli attori recitano con la voce, quasi sempre sussurrata, ma non con il corpo, con lo sguardo, con la carne. Le inquadrature sono lunghe, lente, spesso statiche. I dialoghi ridotti all’osso, fino a diventare astratti. Invece di scavare nei conflitti, li evitano. Invece di dire, tacciono. Ma non ogni silenzio è profondo.
Anche le ambientazioni italiane, così ricche di bellezza e contrasti, restano anonime, spente, non valorizzate. Non c’è tensione, non c’è ritmo, non c’è scarto. Solo un’infinita moderazione visiva e narrativa, che finisce per soffocare storie potenti come questa.
Per il mio bene aveva tutto per scuotere le coscienze e far parlare davvero di adozione. Ma si accontenta di raccontare una vicenda personale, estrema e tragica, senza mai allargare lo sguardo. Non ha il coraggio di stare dentro il dolore dell’adottato, di sporcarsi le mani con la realtà, di prendere posizione.
Chi è adottato capisce. Ma chi non lo è, resta fuori.
E ancora una volta, l’adozione resta una storia da osservare con distanza, non da sentire sulla pelle.
Brilla Marie-Christine Barrault, straordinaria nel ruolo della madre biologica, Anna. L’attrice francese regala al personaggio una profondità che va oltre le parole. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni respiro racconta il peso di una vita vissuta nell’ombra, nel dolore e nella colpa. È immensa nella sua vecchiaia solitaria e sofferente, restituendoci una donna spezzata ma ancora capace di un ultimo, silenzioso atto d’amore.
SPOILER: nel finale, dal sapore consolatorio, Anna – che aveva abbandonato Giovanna a un mese di età – prima di morire le lascia un pezzo di sé: il fegato.
Un gesto estremo, silenzioso, forse tardivo. Prima di lasciarsi andare nel lago e ricongiungersi simbolicamente al figlioletto morto, Anna compie l’unico atto di riconoscimento possibile: salvare la figlia che non aveva voluto, restituendole la vita.