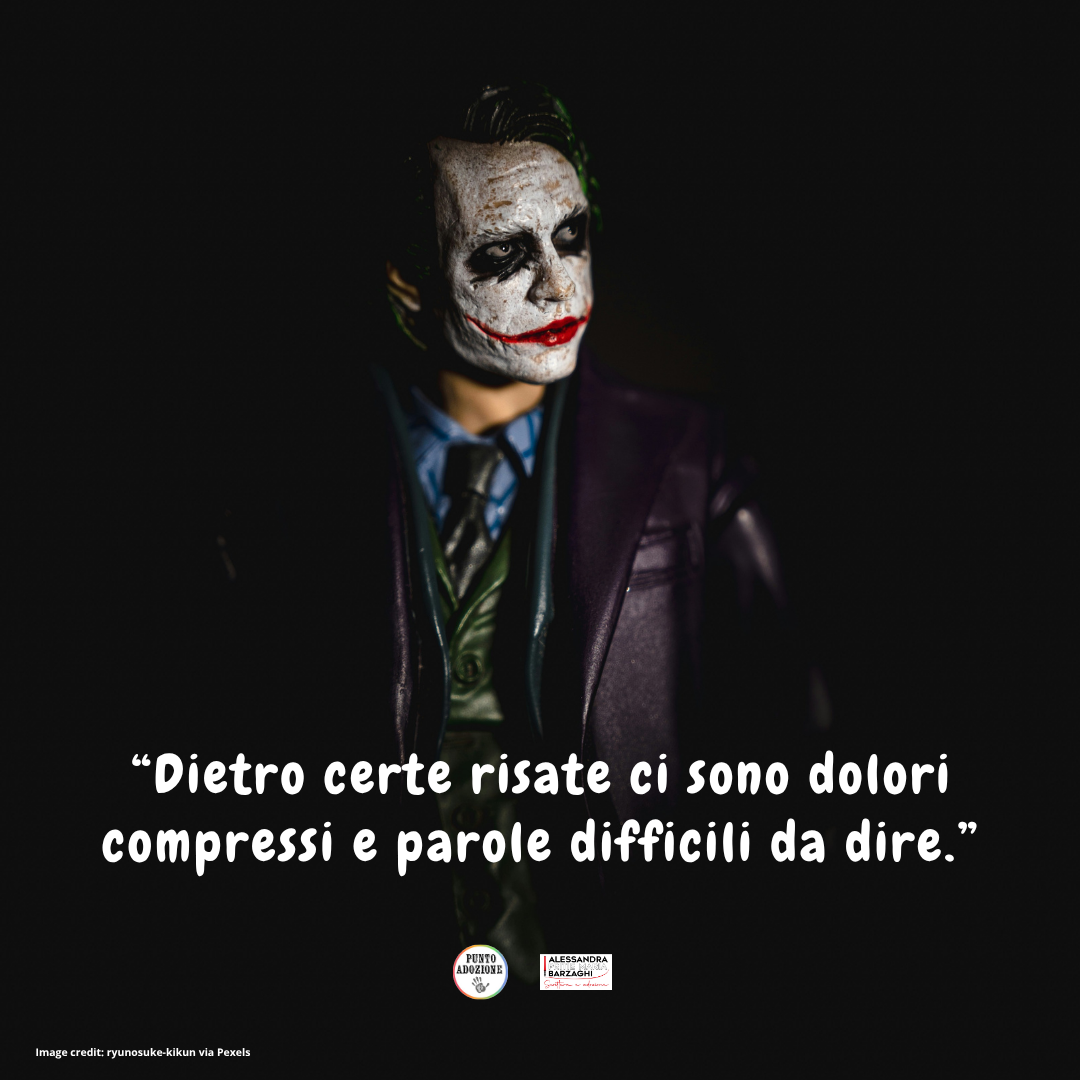Tempo di lettura: 3 minuti
L’altro giorno ho visto Joker 2 – Folie à Deux, il sequel dello straordinario Joker. Rivedere il personaggio interpretato dal monumentale Joaquin Phoenix mi ha portato a riflettere sulla sua iconica risata, e sul parallelo con lo stato d’animo di chi ha vissuto un’esperienza drammatica di abbandono.
Leggi tutto: La risata che nasconde altroPer chi non conoscesse la storia, Joker è uno dei nemici storici di Batman, ma nei due film di Todd Phillips è lui il protagonista.
Ne esce il ritratto di un uomo spezzato, un villain non per natura, ma per storia: per ferite non curate, per abbandoni mai risolti.
Arthur Fleck è un individuo profondamente alienato, che vive con l’anziana madre Penny in un appartamento dei bassifondi di Gotham, una città in preda al degrado sociale.
Sogna di diventare cabarettista, ma la vita lo schiaccia. A causa dei tagli alla spesa pubblica perde l’accesso all’assistenza sociale, subisce pestaggi, viene rimproverato ingiustamente dal suo capo, e il suo senso di frustrazione cresce.
L’unico sollievo è la fantasia, l’illusione di un amore possibile. Ma niente, nella sua vita, è reale.
A un certo punto, Arthur scopre l’amara verità: sua madre soffre di un disturbo delirante e di un disturbo narcisistico di personalità.
Lo adottò spacciandolo per figlio di Thomas Wayne, ma lo abbandonò agli abusi del suo compagno, che lo maltrattò a tal punto da causargli un trauma cerebrale all’origine del suo disturbo.
Arthur soffre di depressione, allucinazioni e di un raro disturbo neurologico che provoca crisi incontrollabili di risata nei momenti di forte tensione: si chiama riso spastico, ed è tipico della sindrome pseudobulbare.
Arthur non ha più voce per comunicare il proprio dolore, così il suo trauma esce in forma di risata, in un cortocircuito emotivo.
Lungi dal paragonare la mia figlioletta a Joker, ma quella risata “sbagliata” nei momenti sbagliati mi ha fatto pensare a quando lei rideva all’improvviso in classe. A quando a volte rideva mentre la sgridavo per una marachella. A quando rideva nei momenti più tesi, più difficili, più emotivamente carichi.
Non era una risata felice.
Era una risata che mascherava qualcosa. Che scappava via da qualcosa.
Guardando Joker, ho rivisto quella risata senza senso apparente, ma carica di significato.
E mi si è confermato ciò che avevo intuito sulla pelle, giorno dopo giorno: che alcuni figli ridono non per leggerezza, ma per non esplodere.
Ridono perché non trovano le parole. Perché la tensione interna è difficile da contenere.
Quella risata diventa una corazza, un modo per non soccombere.
È un’emozione che non si mostra per ciò che è.
Come per Arthur Fleck, anche nei nostri figli può essere una maschera necessaria per restare a galla in una realtà che pesa.
Una maschera che confonde, che disorienta, che può far sorridere chi guarda, ma che dentro, spesso, grida.
Arthur vive in un mondo che pretende il sorriso come forma di accettazione.
Basti pensare al cartello appeso nello spogliatoio dei clown: “Put on a happy face”, o al suo stesso lavoro, che lo costringe a indossare una maschera e a intrattenere, anche quando dentro è a pezzi.
Sua madre gliel’ha ripetuto fin da piccolo: “Tu sei nato per far ridere gli altri.” E lui ci ha creduto.
Per questo si aggrappa ossessivamente all’idea di trovare la battuta giusta, quella che lo farà amare, accettare, applaudire.
Finché, a un certo punto, tutto si rovescia. Arthur dice:
“Pensavo che la mia vita fosse una tragedia. Ma ora mi rendo conto che è una commedia.”
È il momento in cui smette di cercare approvazione e abbraccia il paradosso della sua esistenza.
È il momento in cui diventa Joker.
La sua risata, incontrollabile, è una caricatura grottesca del dover essere felici a tutti i costi. Di dover soddisfare il sogno, i desideri altrui.
Invece di includerlo, quella risata lo isola.
Non comunica gioia, ma disagio. Non fa ridere: disturba, spaventa.
È la risata della marginalità. Di chi è costretto a indossare una maschera sorridente mentre dentro si frantuma.
Allo stesso modo, nella narrazione dell’adozione si parla di gioia, di dono, di rinascita, di amore, di salvezza… tutte parole che stridono con l’esperienza dell’adottato, soprattutto quando non è ancora stata accolta nella sua interezza.
E allora sì, guardare Joker può servire anche a questo:
a ricordarci che ogni risata fuori tempo e contesto può nascondere un dolore che non ha trovato voce.
📌 So bene che Joker è un personaggio estremo. Non intendo in alcun modo accostare chi ha una storia di adozione a figure disturbate o pericolose. Io stessa sono anche figlia adottiva.
Ma a volte, proprio attraverso le storie estreme, possiamo vedere meglio le crepe sottili di quelle quotidiane. E riconoscere, in una risata apparentemente senza senso, un dolore che chiede ascolto.