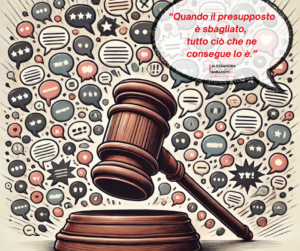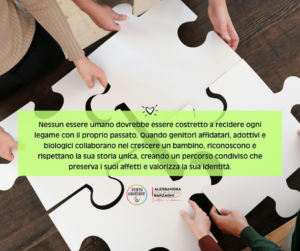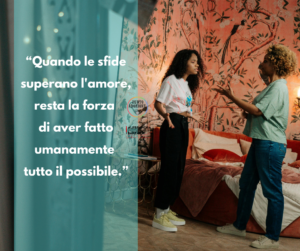Un pensiero personale per chi vive relazioni complesse con un figlio adottivo
Tempo di lettura: 5 minuti
Leggi tutto: Quando l’aiuto è un campo di battagliaCi sono momenti in cui l’aiuto richiesto si trasforma in un campo di battaglia.
Un figlio si presenta con un problema, ti chiede un parere, un orientamento. Tu lo ascolti, ci stai dentro, provi a offrirgli qualcosa che possa essergli utile: uno spunto, un’ipotesi, un affettuoso avvertimento, magari solo una frase di senso.
E da lì parte lo scontro.
Ogni parola viene rifiutata, smontata, rigirata. Ti ritrovi a doverti giustificare per aver fatto quello che ti era stato chiesto. Da punto di riferimento vieni messo alla prova, contraddetto, svalutato.
A me ultimamente succede spesso con mia figlia. Tanto che glielo leggo negli occhi, nella postura rigida prima ancora che parta la reazione. So già che ogni frase verrà presa come un’ingerenza, un’invasione, un affronto. Eppure, è sempre lei a interpellarmi per prima.
Ma ho imparato a subodorare la trappola relazionale, fermandomi ad analizzarla: lei mi testa, mi chiede senza dirlo: mi lasci decidere anche se sto andando a sbattere? Mi accetti anche quando mi contraddico o esagero?
So che non cerca davvero un consiglio, ma una conferma. Vuole vedere se ci sono anche quando attacca. Vuole sapere se l’amore resiste anche al suo rifiuto.
La risposta razionale, quella di buon senso, quella che darei a chiunque altro, con lei non funziona. Perché non è in discussione la logica, ma il legame.
E il legame, quando sei stata adottata, non è mai scontato. Nemmeno se tuo figlio è un giovane adulto. Deve essere verificato ogni tanto.
Lo chiamano DOP, disturbo oppositivo provocatorio. Ma una volta declamato, poi cosa se ne fa un genitore?
Io penso invece che si tratti di un ipercontrollo difensivo che ha un unico vantaggio: sono loro a decidere. Sbagliano? Pazienza. Ma almeno decidono.
Dietro a certe dinamiche non c’è solo il fisiologico desiderio di indipendenza tipico di quell’età. C’è qualcosa di più antico, più viscerale. C’è la lotta per il controllo, che ha radici nel trauma.
Perché chi ha perso tutto, una volta, fa fatica a lasciarsi aiutare: percepisce ogni gesto di cura come non vero, come potenzialmente pericoloso. Ogni consiglio come una minaccia al proprio diritto di scegliere, per una volta tanto.
Chi ha vissuto il trauma della perdita del controllo — della propria vita, del proprio destino — fa fatica a fidarsi. Fidarsi è rischioso. E l’aiuto può attivare vecchie ferite: la paura di dipendere, il timore di essere manipolati, il sospetto che dietro ci sia un secondo fine.
Un gesto di attenzione, fatto con il cuore e senza secondi fini, può essere vissuto come un tentativo di correzione. Di invasione. Come se si volesse aggiustarli. E in quel momento il bisogno di essere lasciati come sono prevale su tutto il resto, anche se finiscono per complicarsi la vita pur di non accogliere la proposta.
È come se dicessero: “Io scelgo che ci sia una parte di me che tu non puoi aggiustare.”
Forse è una difesa. Forse è un modo di esercitare un potere. Forse è l’unico modo che hanno per dire: “Non posso essere sempre messo a posto.”
Mi impongo, a fatica, di non dire nulla. Di lasciarla fare.
Ma poi lei torna, con un altro dubbio, un’altra domanda, un altro campo minato.
E io ricomincio a camminarci dentro, sapendo che il vero nodo non è nel contenuto, ma nella relazione. Nella fatica ad accettare un aiuto che non umilia, a tollerare una guida che non controlla, a credere che la calma di chi ti porge la mano non sia finzione.
A volte si rifugia addirittura nel caos, perché è ciò che conosce meglio.
In questi scambi si gioca una partita molto più profonda.
Non è solo sfida, è sopravvivenza. Accogliere un consiglio può sembrare una resa, può mostrare debolezza.
E la resa è pericolosa quando hai imparato che l’unico modo per non essere di nuovo deluso è fare tutto da solo. Costi quel che costi. Malgrado il risultato.
E allora ho imparato che, a volte, serve solo un passo di lato.
Dire: “Io ti dico come la vedo, poi fai tu.”
Non è disimpegno. È un modo diverso di esserci.
È un esercizio faticoso, perché chiede a noi adulti di essere presenti ma non invasivi, capaci di tollerare il rifiuto senza viverlo come personale.
Ma poi, nel tempo, tra quegli strati granitici di ostinazione, intravedi qualcosa di sorprendente: anche se sembra che rifiutino tutto, qualcosa assorbono.
A volte li vedi riprendere proprio quel suggerimento che avevano respinto, trasformarlo, farlo proprio. Senza mai riconoscertelo.
Io lo intuisco in mia figlia. Anche se fa di tutto per non darlo a vedere.
Perché dare ragione significa ammettere che si è stati aiutati.
E per chi porta dentro di sé la vergogna del bisogno, questo gesto è quasi insostenibile.
Anche solo percepire nel genitore una competenza, un sapere, una forza, li mette a confronto con ciò che ancora non si sentono di essere. E qui siamo sul piano più doloroso: sono intrappolati tra gratitudine e rivendicazione. Sanno di dover fare i conti con la colpa di non poter ricambiare il bene ricevuto. O con la vergogna di doverlo riconoscere. Una pressione che purtroppo arriva da una narrazione sbagliata dell’adozione.
E allora lo provocano quel bene, per dimostrarti che invece può essere falso. E il paradosso è che, mentre lo fanno, ti stanno scegliendo. Anche se non vogliono dirtelo.
Tu sei lì, che tenti di reggere il gioco. A volte esausta. A volte arrabbiata. Ma resti.
E il fatto che sei stabile, cambia tutto. Cambia la vita anche a loro, anche se non lo sanno ammettere.
E così mi ritrovo a pensare che, se non ci fossi — con la mia calma, con la mia chiarezza, con il mio reggere nonostante tutto — lei sarebbe ancora dentro a caos, persa e in balìa.
Sono il perno che lei finge di non vedere, ma attorno al quale gira comunque. E questo, già da solo, è moltissimo.